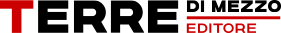Camminare tra orsi e lupi significa entrare in uno degli ecosistemi più affascinanti e complessi d’Europa. Uno di questi è di certo il Parco Nazionale della Maiella. Qui, lungo il Cammino Grande di Celestino (che attraversa il Parco dalla tappa 5 alla tappa 10), il camminatore attraversa un territorio che conserva ancora la presenza dei grandi carnivori appenninici. Un ambiente che racconta la convivenza millenaria tra uomo e natura, fatta di paure, leggende, conflitti ma anche di nuove opportunità di conoscenza e rispetto.
Articolo in collaborazione con il Parco Nazionale della Maiella

La Maiella è considerata il “cuore selvaggio” dell’Appennino, un laboratorio naturale dove vivono specie rare e uniche, come l’orso bruno marsicano e il lupo appenninico. Incontrarli può essere considerato un evento più unico che raro, ma sapere che abitano questi boschi e valloni arricchisce l’esperienza del camminatore, trasformando il passo in un atto di consapevolezza ecologica.
In questo articolo scopriremo il ruolo di orsi e lupi nell’ecosistema della Maiella, le regole per camminare in sicurezza e il valore che la loro presenza porta al Cammino di Celestino.

Camminare tra orsi e lupi: perché la Maiella è speciale
Camminare tra orsi e lupi nella Maiella significa muoversi in un ambiente che unisce spiritualità, storia e biodiversità. Questo massiccio, definito “la montagna madre” d’Abruzzo, si estende per oltre 74.000 ettari e presenta una straordinaria varietà di ecosistemi.
Si passa dalle vallate boscose ricche di faggi e querce, fino alle praterie d’alta quota, tra le più elevate degli Appennini. Proprio questa diversità di ambienti rende possibile la presenza di specie rare e protette, che trovano rifugio in un mosaico naturale quasi intatto.
La Maiella è un vero e proprio “laboratorio vivente” per biologi ed ecologi. Qui convivono oltre 2.000 specie vegetali, molte delle quali endemiche, insieme a rapaci, cervi e caprioli che costituiscono la base alimentare per i grandi carnivori. Per questo è considerata una delle aree più preziose d’Europa, riconosciuta anche dall’UNESCO come Geoparco Mondiale. Insomma, un paesaggio che racconta la resilienza della natura e la capacità dell’uomo di tutelarla.
L’orso bruno marsicano
L’orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) è considerato il grande emblema della fauna appenninica. Si tratta di una sottospecie dell’orso bruno europeo, ma unica e endemica dell’Appennino centrale, localizzata soprattutto tra il Parco Nazionale della Maiella e il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Questa popolazione, stimata oggi in appena 50- 70 individui, rappresenta un patrimonio biologico irripetibile, tanto da essere inserita tra le specie a rischio critico di estinzione secondo la Lista Rossa dell’IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura).
Dal punto di vista morfologico, l’orso marsicano presenta caratteristiche che lo distinguono dai suoi “cugini” alpini o balcanici. Ha dimensioni mediamente più contenute, con maschi adulti che raramente superano i 150-180 kg, un cranio più allungato e un comportamento particolarmente schivo. A dispetto della mole, la sua dieta è prevalentemente vegetariana. Oltre il 70% degli alimenti consumati è costituito da erbe, radici, frutti spontanei e bacche, cui si aggiungono insetti, larve e occasionalmente piccoli animali o carcasse. Questo regime alimentare ha un’importanza ecologica enorme Infatti, l’orso marsicano agisce come “giardiniere della foresta”, favorendo la dispersione dei semi e il rinnovo degli ecosistemi.
Il valore dell’orso non è soltanto ecologico, ma anche culturale e simbolico. Da secoli accompagna l’immaginario delle popolazioni montane abruzzesi, tra leggende, paure ancestrali e racconti popolari. Tuttavia, proprio il difficile rapporto con l’uomo è stato per lungo tempo una minaccia. Basti pensare al bracconaggio e agli avvelenamenti, che hanno drasticamente ridotto il numero di individui nel corso del Novecento, portandolo sull’orlo dell’estinzione.
il Parco Nazionale della Maiella, in sinergia con istituti di ricerca e associazioni, ha appena concluso due progetti LIFE finanziati dalla Comunità Europea: Si tratta del LIFE SAFE CROSSING e LIFE ARCPROM con l’obiettivo di proteggere gli individui esistenti, riducendo i rischi di mortalità legati a investimenti stradali e favorendo una pacifica coesistenza con le attività.
Incontrare un orso bruno marsicano durante un’escursione o un cammino è un evento rarissimo, quasi impossibile per un camminatore comune. Eppure, sapere che questa specie vive ancora nella Maiella dà un valore diverso all’esperienza. Ogni traccia, ogni graffio sugli alberi, ogni impronta nel fango diventa il segno tangibile della presenza di un animale che incarna la perseveranza della natura. Camminare nei suoi territori significa quindi vivere un’esperienza di profonda consapevolezza.

Il lupo appenninico
l lupo appenninico (Canis lupus italicus) è una delle sottospecie più affascinanti del lupo grigio, riconosciuta scientificamente soltanto nel XX secolo grazie a studi morfologici e genetici. Vive in branchi socialmente organizzati, guidati da una coppia dominante, e occupa un ruolo cruciale come predatore apicale all’interno degli ecosistemi appenninici. La sua presenza contribuisce a mantenere l’equilibrio naturale, regolando le popolazioni di ungulati selvatici e limitando l’eccessivo impatto di cervi, caprioli e cinghiali sulla vegetazione.
Per secoli il lupo è stato vittima di persecuzioni spietate. Considerato un nemico dei pastori e responsabile delle perdite negli allevamenti, è stato cacciato senza tregua fino a ridursi, negli anni Settanta, a poche centinaia di esemplari confinati tra Abruzzo e Calabria. L’Italia rischiava di perdere per sempre un elemento chiave della propria biodiversità. A cambiare la storia è stato il riconoscimento del suo valore ecologico e l’introduzione di leggi di tutela che ne hanno sancito la protezione integrale.
Eccone degli esempi:
- 1971 – Decreto Ministeriale “Operazione San Francesco”: il Ministero dell’Agricoltura e Foreste avvia un progetto di studio e conservazione del lupo, grazie al WWF e al biologo Luigi Boitani. È il primo vero passo di tutela.
- 1976 – Legge 968/1977 sulla fauna selvatica (poi sostituita dalla Legge 157/1992): riconosce la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato. Il lupo diventa specie protetta su tutto il territorio nazionale.
- Convenzione di Berna (1979): trattato europeo ratificato dall’Italia nel 1981, che inserisce il lupo tra le specie rigorosamente protette.
- Direttiva Habitat (92/43/CEE): normativa europea che tutela habitat e specie di interesse comunitario. Il lupo è inserito negli Allegati II e IV, quindi beneficia di protezione speciale e richiede la designazione di zone SIC/ZSC (oggi Rete Natura 2000).
- Progetti LIFE dell’Unione Europea: dal LIFE Natura negli anni ’90 fino a iniziative più recenti, hanno sostenuto monitoraggi, misure di prevenzione dei danni agli allevatori e campagne di sensibilizzazione.
Grazie a queste misure, la popolazione di lupo in Italia è passata da circa 100 individui stimati negli anni ’70 a oltre 3.000 distribuiti lungo l’Appennino e in espansione sulle Alpi.
Nella Maiella le condizioni ambientali, ricche di prede e relativamente isolate, offrono a questa specie un habitat ideale. Studi condotti tramite radiocollari e analisi genetiche hanno permesso di comprendere meglio i suoi spostamenti, le dinamiche sociali e la distribuzione territoriale dei branchi. I dati raccolti mostrano come i lupi siano in grado di coprire decine di chilometri in una sola notte, confermando l’adattabilità e l’eccezionale resistenza di questa specie.
Il ritorno del lupo ha implicazioni ecologiche positive, ma porta con sé anche nuove sfide. I conflitti con la zootecnia vanno ulteriormente mitigati e richiedono misure concrete di prevenzione, come l’uso dei cani da guardiania, recinti elettrificati e sistemi di sorveglianza e deterrenza innovativi. La ricerca scientifica e la sensibilizzazione delle comunità locali sono strumenti essenziali per consolidare la convivenza.
Avvistare un lupo è un’esperienza rara e incredibile. La maggior parte delle persone non lo vedrà mai direttamente, ma potrà coglierne le tracce: un ululato lontano, un’impronta fresca sulla neve, un segno del passaggio che restituisce al camminatore la consapevolezza di trovarsi in un paesaggio ancora autenticamente selvatico. Sapere che i lupi abitano questi boschi e transitano su questi sentieri rende la Maiella un luogo unico in Europa e trasforma la nostra avventura lungo il Cammino di Celestino in un viaggio dentro la memoria profonda della natura.

Come convivere con i grandi predatori
La presenza stabile di orsi e lupi nella Maiella dimostra che l’ecosistema conserva ancora un equilibrio naturale di grande valore. Tuttavia, convivere con i grandi carnivori non è mai stato semplice. Per secoli, pastori e contadini hanno percepito questi animali come una minaccia diretta alle greggi e alla sicurezza delle comunità montane. Non a caso, molte leggende popolari dell’Appennino descrivono l’orso come un predatore feroce e il lupo come un nemico da temere. In realtà, la maggior parte dei conflitti derivava dall’assenza di strumenti di prevenzione e da un uso del territorio che esponeva gli animali domestici a facili predazioni.
Oggi le conoscenze scientifiche hanno permesso di ribaltare questa prospettiva. Progetti nazionali e internazionali hanno introdotto sistemi innovativi per ridurre gli impatti sugli allevatori: recinzioni elettrificate, dissuasori acustici e soprattutto l’impiego dei cani da guardiania, come i Pastori Maremmano-Abruzzesi, che rappresentano un metodo tradizionale ma ancora estremamente efficace. Parallelamente, programmi educativi e campagne di sensibilizzazione aiutano le comunità locali e i visitatori a riconoscere l’importanza ecologica dei carnivori.
La convivenza è dunque possibile, a condizione che venga sostenuta da politiche di tutela coerenti, investimenti nelle aree rurali e un dialogo costante con chi vive quotidianamente la montagna e i pascoli. La sfida non riguarda solo la protezione di orsi e lupi, ma anche la capacità dell’uomo di immaginare un futuro in cui le attività tradizionali possano coesistere con una natura autenticamente selvaggia.
Linee guida per camminare in sicurezza
Camminare in un territorio che ospita orsi e lupi non significa esporsi a un pericolo costante. Questi animali evitano ambienti frequentati dall’uomo e raramente scelgono di avvicinarsi. Tuttavia, esistono comportamenti semplici che riducono ogni possibile rischio e aiutano a vivere l’esperienza del Cammino di Celestino con consapevolezza.
Regole fondamentali per il camminatore:
- Mantenere la calma e la distanza: se si avvista un orso o un lupo, non bisogna correre né compiere gesti o movimenti bruschi, ma osservare l’animale a distanza senza tentare di avvicinarsi e possibilmente allontanarsi con cautela. Cercare la foto sensazionale avvicinandosi è dannoso per loro e pericoloso voi che distratti potreste inciampare e farvi male seriamente.
- Gran parte delle specie sono elusive e temono l’uomo, quindi avvicinarsi vuol dire restringere il loro spazio di fuga aumentando così la possibilità di essere caricati e magari travolti.
- Non abbandonare cibo o rifiuti: gli scarti attirano la fauna selvatica e possono alterarne i comportamenti naturali.
- Custodire i cani al guinzaglio: un cane libero può inseguire un lupo o disturbare un orso, creando situazioni potenzialmente pericolose (attenzione: le tatte 7 e 8 del Cammino non sono percorribili con il cane).
- Evitare di seguire le tracce: orme o graffi sugli alberi sono segnali territoriali.
Queste buone pratiche hanno una duplice funzione. Infatti, proteggono il camminatore e garantiscono che gli animali mantengono la loro naturale diffidenza verso l’uomo, condizione indispensabile per la loro conservazione. Camminare in sicurezza, in fondo, significa rispettare la natura che ci accoglie.
Perché è raro ma prezioso avvistare orsi e lupi
Quando ho percorso il Cammino Grande di Celestino a maggio, mi sono accorto di quanto il paesaggio della Maiella trasmetta la sensazione di ospitare un patrimonio incredibile. Vedere orsi e lupi è rarissimo, e non potrebbe essere altrimenti: entrambi evitano l’uomo e preferiscono rifugiarsi in zone appartate. La maggior parte dei camminatori non li incontrerà mai direttamente, eppure ogni passo porta con sé la consapevolezza che questi animali ci osservano da lontano, nascosti dal bosco o dal vento delle praterie d’alta quota. Dopo tutto, attraversando una delle zone con densità di popolazione più elevata d’Europa, abbiamo potuto notare in più occasioni tracce della presenza del lupo. Ogni orma riconosciuta o fatta identificata sul sentiero è stata per me un’emozione incredibile.
Per me il vero incontro è questo:una traccia impressa nel terreno, il tronco di un faggio graffiato,le loro fatte. Sono indizi che raccontano la loro presenza e che rendono unico il camminare in Maiella. Sapere che questi grandi carnivori vivono ancora qui e condividono i sentieri che percorriamo anche noi “ospiti” camminatori è già di per sé un privilegio che significa attraversare un ambiente che conserva intatta la sua anima più ancestrale.
Conclusione
Camminare lungo il Cammino di Celestino significa entrare in contatto con la parte più autentica della Maiella. Qui la montagna custodisce un equilibrio delicato, fatto di silenzi, di tracce discrete e di specie che altrove non trovano più spazio. L’orso bruno marsicano e il lupo appenninico sono la prova vivente che questa terra è ancora capace di ospitare la grande fauna selvatica, e soprattutto che la convivenza con essa è possibile.
Quando ho percorso il cammino ho percepito questa presenza in maniera palpabile, anche senza incontrarla direttamente. Il richiamo a rallentare il passo e osservare con attenzione è stato forte. È così che il cammino diventa allora un’esperienza completa. Un invito a rallentare e soffermarsi, con rispetto, a sentirsi ospiti e non padroni, a riconoscere che proteggere orsi e lupi significa garantire un futuro alla biodiversità di cui facciamo parte anche noi.