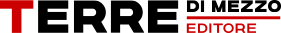Apriamo i social e vediamo l’ennesimo post di qualche amico che si gode un calice di vino rosso in una vigna al tramonto. Poi pensiamo ai nostri “viaggi tipo”: zaino in spalla, scarpe da trekking (a volte infangate), sudore misto ad allegria e pranzi con panini un po’ schiacciati nello zaino, da goderci davanti ad un bel panorama. Nulla da togliere ai nostri amati panini schiacciati, ma oggi vi racconteremo perché questi due mondi, quello del cammino e quello dell’enogastronomia, che sembrano così distanti, in realtà non lo sono affatto.

In questo articolo vi racconteremo i Sentieri del Carignano, un nuovo itinerario tematico che ci dimostra che camminare e l’enogastronomia non solo possono coesistere, ma si completano.
Articolo in collaborazione con la Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara.
Informazioni sui Sentiero del Carignano
Siamo nella Sardegna sud-occidentale, nel Sulcis Iglesiente, dove la Fondazione del Cammino Minerario di Santa Barbara ha valorizzato un percorso che unisce tutto quello che amiamo: viaggio lento, scoperta del territorio, storia ed enogastronomia di alto livello.
I Sentieri del Carignano non è un cammino a sé stante, ma un itinerario tematico proprio all’interno del tracciato ufficiale del Cammino Minerario di Santa Barbara, 500 km di sentieri che attraversano il Parco Geominerario storico ambientale della Sardegna. Il percorso completo si sviluppa lungo gli antichi cammini minerari, toccando chiese, luoghi di culto, tra cui luoghi davvero iconici e i paesaggi costieri per cui la Sardegna è famosissima.
Nei Sentieri del Carignano, però, il protagonista non è “solo” il paesaggio o la storia mineraria, ma il vino. Più precisamente, il Carignano del Sulcis DOC, vitigno autoctono che esiste su queste terre da secoli e che produce un rosso corposo, morbido, avvolgente.
L’idea che sta alla base di questo itinerario è quella di camminare attraverso le zone vocate alla produzione di questo vino, incontrare i produttori, visitare le cantine, e comprendere il legame profondo tra il territorio e il suo vino simbolo.
Nel frattempo, si attraversano siti archeologici fenicio-punici, miniere di barite, grotte carsiche e spiagge che hanno contribuito alla fama dell’isola.
Il percorso conta più di 220 km, suddivisi in 12 tappe, che si possono affrontare nella loro totalità o in parte, a seconda del tempo che si ha a disposizione e a seconda del proprio grado di allenamento.
Il Carignano del Sulcis: il protagonista del cammino
Se non siete esperti di vini, nessun problema: non serve esserlo. Ma comprendere la storia del Carignano del Sulcis vi aiuterà ad apprezzare meglio ogni calice degustato lungo il percorso.
Questo vitigno arriva in Sardegna secoli fa, portato dai colonizzatori spagnoli nel 1300, che lo piantano direttamente nel terreno.
Trova qui il suo habitat ideale: terreni sabbiosi e calcarei, vicinanza al mare, vento che tiene lontane le malattie. La vera particolarità è che queste viti sono rimaste intatte fino ad oggi, continuando a crescere “a piede franco“, con i propri “piedi”, le proprie radici originali.
Per capire quanto sia raro, bisogna fare un passo indietro: nell’Ottocento la fillossera, un parassita devastante, distrusse gran parte dei vigneti europei. Nel Sulcis, invece, la fillossera non è mai arrivata, probabilmente grazie alla sabbia e alla salinità del suolo.
Le viti di Carignano, quindi, non hanno mai avuto bisogno di essere innestate e continuano a crescere come furono piantate del 1300, con radici che affondano nel terreno fino a 10-15 metri di profondità, assorbendo tutti i nutrienti e i minerali della terra in modo diretto e integrale.
Al calice, il Carignano del Sulcis ha un colore rubino intenso, quasi impenetrabile.
Al naso arrivano i frutti rossi maturi: ciliegia, mora, prugna, mescolati a note speziate. In bocca è morbido, avvolgente, con tannini equilibrati che non seccano il palato ma accompagnano fino a un finale lungo, persistente.
Invece, per quanto riguarda gli abbinamenti, la tradizione vuole il Carignano con piatti robusti della cucina sarda: porceddu, cinghiale, formaggi stagionati. Ma anche, e qui sta la sorpresa, con il tonno rosso, presenza costante nel Sulcis grazie alle tonnare storiche.
L’abbinamento vino rosso-pesce può sembrare strano, ma quando assaggerete il Carignano con tonno scottato o con la bottarga, capirete che certe regole esistono solo per essere infrante.
Nelle tappe si avrà la possibilità di fermarsi nelle cantine, non “solo” per degustare il vino, ma per incontrare chi lo produce, ascoltare le storie delle famiglie che da generazioni lavorano in quelle terre, per capire cosa significa fare vino in un posto dove la natura è generosa, ma talvolta ostinata.
Le 12 tappe dei Sentieri del Carignano

Come anticipato, l’itinerario dei Sentieri del Carignano è composto da 12 tappe che partono da Nuxis e arrivano a Cortoghiana, toccando anche l’isola di Sant’Antioco e l’isola Carloforte.
Lo si può percorrere nella sua interezza oppure si possono scegliere le tappe che interessano di più.
Tappa 1: Da Nuxis a Santadi (20,3 km, +625m, -689m)
(Tappa 18 del Cammino Minerario di Santa Barbara)
Si parte con una tappa che concentra archeologia e geologia. Il percorso attraversa la cava di barite di Rio Bacchera, passa vicino alla cava romana di onice (non visitabile), tocca il Pozzo Sacro di Tattinu, la chiesa bizantina di Sant’Elia e arriva fino alla tomba dei giganti Sa Fraigada di Barrancu Mannu, uno dei siti di età nuragica più importanti della Sardegna.
Per chi ama la storia antica, questa tappa è un concentrato di testimonianze millenarie.

Tappa 2: Da Santadi a Is Zuddas (18km, +192m, -217m)
(Tappa 19 del Cammino Minerario di Santa Barbara)
Qui i vigneti del Carignano si alternano a testimonianze archeologiche, come il Menhir di Luxia Arrabiosa, la necropoli di Pani Loriga, e le tracce dell’attività estrattiva, come la miniera di Su Benatzu.
Ma l’highlight della tappa sono le Grotte di Is Zuddas, fenomeni carsici sotterranei spettacolari, con stalattiti e stalagmiti che formano vere e proprie cattedrali di pietra.
In questa tappa si possono visitare due cantine: la Cantina Santadi, situata a pochi chilometri in linea d’aria dalle spiagge e dalle dune bianche di Porto Pino, e la Cantina Taris, realtà a gestione familiare che racconta una storia di tradizioni e persone, prima ancora che di vini.
Tappa 3: Da Is Zuddas a Masainas (16,9km, +317m, -364m)
(Tappa 20 del Cammino Minerario di Santa Barbara)
Questa tappa parte con uno strappo in salita, da 102 metri a 374 metri di quota. Una volta superato, però, il percorso diventa più dolce. Si attraversano cave di barite, si incontrano Domus de janas (le antiche tombe scavate nella roccia) e nuraghi. Il paesaggio è coperto da un manto vegetale lussureggiante, con bellissimi esemplari di ginepro, e ogni tanto si aprono scorci da cui si riesce a vedere fino al mare.
L’arrivo è a Masainas, piccolo centro dell’entroterra, dove ci si può riposare prima delle ultime due tappe che condurranno verso la costa.
La Cantina Giba è tappa d’obbligo. Unendo tradizione e innovazione enologica, in meno di 10 anni, questa cantina ha conquistato i più prestigiosi riconoscimenti del settore.
Tappa 4: Da Masainas a Candiani (20,2km, +328m, -362m)
(Tappa 21 del Cammino Minerario di Santa Barbara)
Dalla pianura del Basso Sulcis fino alla costa. Questa tappa è un mix completo: tracce minerarie nel tratto iniziale, nuraghi (il Nuraxi Mesu in partenza e il Nuraghe Arresi vicino a Sant’Anna Arresi), e poi il mare.
Gli stagni pescosi, le dune bianche e la spiaggia di Porto Pino, una delle più belle della Sardegna, accompagnano il finale del percorso.
Tappa 5: Da Candiani a Tratalias (26,3km, +417m, -421m)
(Tappa 22 del Cammino Minerario di Santa Barbara)
La tappa più lunga e impegnativa. Ma “impegnativa” qui significa soprattutto “lunga”, perché il percorso è agevole.
Si cammina sulle scogliere di Porto Pinetto e Portu Su Trigu, con vista costante sul golfo di Palmas, si attraversano grandi distese di vitigni (qui si trovano sia Carignano che Vermentino) e poi ci si addentra nel complesso dunale retrostante alla spiaggia di Sa Salina. Si passa dalla spiaggia di Porto Botte e infine si arriva a Tratalias.
Una giornata intera di cammino, ma con paesaggi che cambiano continuamente: costa, campagna, dune, vigneti.
In questa tappa si trova la Cantina Mesa, dove è possibile concludere la giornata con un’ottima degustazione.
Tappa 6: Da Tratalias a Sant’Antioco (15,6 km, +204m, -184m)
(Tappa 23 del Cammino Minerario di Santa Barbara)
Una tappa breve che permette di dedicare tempo al ricco patrimonio storico-religioso del territorio. Si possono visitare le chiese romaniche di Santa Maria di Monserrato e Santa Maria di Palmas, per arrivare fino alla basilica paleocristiana di Sant’Antioco. Il ritmo rilassato del percorso consente di osservare l’avifauna che popola le saline di Sant’Antioco, area umida di grande valore naturalistico.
Nell’isola di Sant’Antioco troveremo la cantina “Sardus Pater”. Costituita nel 1949 come società cooperativa, ha iniziato l’attività nel 1955. Nel corso degli anni la produzione dei vini si è affinata e ha puntato soprattutto alla valorizzazione del vitigno Carignano.

Tappa 7: Isola di Sant’Antioco
Non abbiamo ancora informazioni su questa tappa, ma al più presto le integreremo.
Tappa 8: Da Carloforte a Capo Sandalo Becco (14,1 km, +510m, -431m)
Nell’ottava tappa si scoprirà la parte centrale dell’isola vulcanica, un territorio modellato dal lavoro dei liguri tabarchini che l’abitano da quasi tre secoli. Il percorso si snoda tra vigneti e orti battuti dal vento, attraversa pinete che ricoprono anche i versanti più ripidi, e nella parte finale raggiunge le scogliere tra Capo Becco e Capo Sandalo.
Il tracciato incontra anche testimonianze del passato estrattivo di San Pietro: le antiche piste solcate dai carrelli per il trasporto del minerale e le ex miniere di ocra e manganese del Becco.
Tappa 9: Da Capo Sandalo a Calasetta (18,5 km, +300m, -379m)
Questa tappa attraversa la parte meridionale dell’isola di San Pietro per poi fare ritorno via mare all’isola madre.
Il percorso sale al monte Sepoltura, immerso nella macchia mediterranea, e prosegue tra la spiaggia e la duna de La Caletta. L’interno dell’isola alterna campi coltivati e aree lasciate alla natura, fino a raggiungere le uniche zone pianeggianti del territorio e la zona umida che precede Carloforte. Qui si incontrano le antiche saline, piccolo patrimonio ambientale e produttivo dell’isola.
Si conclude così un percorso di due giorni tra le estremità occidentale e orientale di San Pietro: rocce vulcaniche, trasparenze del mare e caruggi del centro storico compongono il ritratto dell’isola.
Tappa 10: Da Calasetta a Sant’Antioco (15,5 km, +211m, -243m)
Questa tappa collega Calasetta, la cittadina bianca e azzurra, al centro di Sant’Antioco, attraversando la parte nord-orientale dell’isola. Il percorso si snoda tra vigneti e zone lagunari, offrendo un itinerario molto diverso rispetto alle tappe precedenti.
Durante questa tappa si potranno visitare ben quattro differenti cantine: Cantina Calasetta, Tenuta La Sabbiosa, Piede Franco e Tenuta Agus.
Tappa 11: Da Sant’Antioco a Carbonia (22,8 km, +262m, -182m)
(Tappa 24 del Cammino Minerario di Santa Barbara)
Tra i tratti più lunghi dell’itinerario, questa tappa è però tra le più semplici da affrontare dal punto di vista tecnico.
Il tracciato segue per gran parte l’antica linea delle Ferrovie Meridionali Sarde (FMS), oggi convertita in pista pedonale e ciclabile. Questa ferrovia fu operativa per circa cinquant’anni, dai primi anni Venti ai primi anni Settanta del Novecento, e rappresentò un’arteria fondamentale per il territorio: collegava le persone e trasportava il carbone estratto dalla Grande Miniera di Serbariu verso il porto di Sant’Antioco.
Nell’undicesima tappa si potrà visitare l’azienda Agricola Sant’Andrè.
I gestori dicono che la loro non è una cantina: è un patto antico con la terra, poiché ogni bottiglia racconta la Sardegna autentica: la sabbia, il sale, la macchia mediterranea, la pazienza delle stagioni.
Tappa 12: Da Carbonia a Cortoghiana (22 km, +384m, -403m)
(Tappa 25 del Cammino Minerario di Santa Barbara)
L’ultima tappa dei Sentieri del Carignano attraversa la storia di epoche diverse: si parte dalla miniera di carbone di Serbariu, testimonianza del recente passato industriale, per arrivare alla miniera di Nuraxi Figus, sito di archeologia antica. L’intero tracciato è disseminato di testimonianze che coprono circa cinquemila anni di presenza umana nel territorio, trasformando il percorso in un vero e proprio museo diffuso all’aperto.
Quest’ultima tappa conduce alla Cantina Esu, che racchiude in sé la storia dell’intero cammino e dell’isola: miniere e vino, fatica e terra.
La storia della cantina inizia nel 1953, quando il padre dell’attuale proprietario, assunto come minatore a diciotto anni dalla Carbosarda, continua a coltivare il podere di famiglia nonostante il duro lavoro in miniera. Nel 1958 impianta il primo vigneto di Carignano a piede franco in quei terreni sabbiosi. Oggi quei vigneti producono un vino dal colore intenso e scuro, nero come il carbone che permea ancora quella terra.
Qui, nell’ultima cantina del percorso, si chiude il cerchio prima del ritorno a casa. Un calice finale che porta con sé tutti i chilometri percorsi, i paesaggi attraversati e le storie incontrate lungo i Sentieri del Carignano.

Info pratiche Sentieri del Carignano
Difficoltà
Il percorso è classificato come media difficoltà: il cammino è perlopiù pianeggiante, le distanze giornaliere mediamente sono di 20 km, mentre la tappa più lunga è di 26 km.
Il nostro consiglio è quello di partire con un minimo di allenamento e fare un po’ di pause lungo il cammino.
Vi ricordiamo che c’è la possibilità di scegliere anche delle tappe, quelle che vi interessano di più, e concentrarvi su quelle se avete meno giorni a disposizione.
Quando andare
I periodi migliori sono la primavera (aprile-maggio), quando la macchia mediterranea è in fiore e le temperature sono più miti, e l’autunno (settembre-ottobre), stagione della vendemmia.
In estate le temperature possono essere molto alte, soprattutto nelle tappe che attraversano zone senza ombra. Anche d’inverno il cammino è fattibile, ma alcune strutture potrebbero essere chiuse.
L’autunno, quindi, è la stagione che vi consigliamo per questo tratto, perché è il periodo della vendemmia e si avrà la possibilità di vedere i vigneti in piena attività.
Dove dormire
Lungo il percorso trovi alloggi nei vari centri abitati, potete optare per B&B, agriturismi o piccole strutture ricettive.
Non aspettatevi strutture di lusso, ma posti familiari, spesso gestiti da persone locali che conoscono il territorio e possono darvi consigli per il vostro cammino.
Come organizzare il cammino
Puoi organizzare il cammino in autonomia oppure affidarti a operatori locali che offrono pacchetti (a volte con trasporto bagagli), prenotazioni cantine e alloggi già organizzati.
Potrete scaricare le tracce GPX dal sito del ufficiale dei Sentieri del Carignano: caricatele sul telefono o su un GPS, e via che si parte!
Cosa portare
Oltre all’attrezzatura classica da cammino, vi consigliamo di portare una borraccia in più oppure una sacca idrica capiente: in alcune tappe i punti d’acqua non sono frequentissimi.
Consiglio: se viaggiate in treno e traghetto, per l’ultima tappa, lasciate spazio nello zaino per una bottiglia di Carignano da portare a casa come ricordo!
I Sentieri del Carignano ci permettono di arricchirci chilometro dopo chilometro, in cammino e anche a tavola, attraverso le tradizioni della terra che ci ospita.
Perché il cibo e il vino non sono solo piaceri da consumare, ma racconti di un territorio.
Buoni passi (e buon vino)!