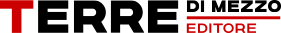Un cammino tra montagne, borghi antichi e sapori autentici. Il Cammino del Gran Sasso nasce dall’idea di tre amici per valorizzare un territorio straordinario dell’Abruzzo, unendo natura, cultura e buona tavola. Cinque tappe ad anello conducono tra paesaggi selvaggi e paesi fermi nel tempo come Rocca Calascio e Santo Stefano di Sessanio, offrendo ai camminatori piatti della tradizione e prodotti unici come il Canestrato di Castel del Monte. Un’esperienza che nutre corpo, mente e spirito, e che sta ridando nuova vita alle comunità locali.
Ogni cammino è fatto di tanti aspetti. C’è quello naturalistico e paesaggistico in cui ci troviamo immersi, che ci riempie gli occhi mentre lo percorriamo; ci sono l’aspetto culturale e sociale, che ci arricchiscono mentre scopriamo mondi diversi dal nostro, tramite la storia dei luoghi, le persone che li abitano e quelle che incontriamo sulla via, in movimento come noi. Per molti c’è l’aspetto spirituale, che scava in profondità giorno dopo giorno in una dimensione diversa eppure connessa alla nostra vita quotidiana, e quello fisico, di contatto con il proprio corpo che diventa il mezzo attraverso cui il cammino è possibile.
Al crocevia di tutti questi aspetti, c’è anche quello enogastronomico, in cui i prodotti della terra che si attraversa, coltivati e preparati dalle persone del posto secondo tradizioni più o meno antiche, nutrono un corpo stanco e affamato e al tempo stesso ritemprano la mente curiosa e lo spirito in ricerca. Che lo viviamo o meno anche come un veicolo di soddisfazione e di scoperta, il cibo è come il riposo qualcosa per noi di fondamentale. Nasce così un ciclo di articoli dedicato ad approfondire gli aspetti enogastronomici di tanti dei nostri Cammini italiani, ognuno con le proprie specificità e chicche da scoprire.

Il Cammino del Gran Sasso: nato dall’idea di tre amici per valorizzare il territorio
Questo primo episodio lo dedichiamo al Cammino del Gran Sasso, un cammino di montagna in Abruzzo nato dall’idea di tre amici e soci, due guide di montagna e una guida turistica, che si sono chiesti che cosa mancasse nel proprio territorio per valorizzarlo al meglio. «Abbiamo capito che mancava proprio un cammino», racconta Federico. L’idea è stata da subito quella di coinvolgere il tessuto locale, così da dare opportunità di lavoro alla comunità, evitare la crescente emigrazione e portare a una società più aperta. «Ora siamo al terzo anno e abbiamo acquisito più credibilità e fiducia da parte dei locali».
Dopo uno studio del territorio e delle possibili tappe – che oggi sono 5 –, Federico e gli altri hanno cominciato a porsi domande. «Di cosa hanno bisogno i camminatori?», si sono chiesti. Di dormire, di mangiare, dei servizi di base. E poi, a seguire, anche di quelli accessori, dalla credenziale, al trasporto bagagli. «Il prossimo anno – racconta –, offriremo anche una guida e un tragitto dedicato alle biciclette, che ora mancano».
Il cammino attuale, ad anello, è stato pensato per essere fruibile da più persone possibili, e comincia da Fonte Cerreto, alla base della funivia del Gran Sasso nel comune dell’Aquila. Dopo una prima tappa più lunga di circa 22 km, obbligata visto che nel mezzo non c’è nulla, a parte la natura di Campo Imperatore e del Canyon dello Scoppaturo, le tappe successive sono più brevi e attraversano paesi suggestivi come Rocca Calascio, Santo Stefano di Sessanio, Barisciano, per tornare poi al punto di partenza, con servizi ricettivi per un totale di più di mille posti letto, una ricca varietà di ristoranti e visite guidate. Non può mancare, ovviamente il cibo locale con le sue eccellenze.

Il pranzo sulla prima tappa, un assaggio di tutte le eccellenze locali
Durante la prima tappa, il Cammino propone e prepara per i camminatori un pranzo con prodotti a km quasi zero: pecorino, salumi locali, cereali e legumi coltivati nella zona – la lenticchia di Santo Stefano di Sessanio, che ora è anche presidio Slow Food, cicerchie, farro –, cucinati e aromatizzati con erbe come santoreggia ed elicriso, crostate fatte con le farine di solina e di rosciola, grani antichi resistenti all’alta quota, che costituivano il prodotto di un’agricoltura una volta di sussistenza, e ora di alta qualità.
Gli agricoltori e allevatori locali hanno capito il potenziale di questo cammino. «Il farro viene coltivato a 1350 metri nel Piano delle Locce, insieme a tutte le cultivar del nostro territorio, nell’unica zona recintata di tutto il cammino. Insieme alla solina e alla rosciola, li usiamo per preparare pane con cui accompagnare i formaggi e i salumi, e crostate», spiega Federico. E ancora, c’è la patata turchesa, semidolce, tra quelle importate dall’America dopo il Cinquecento, e mai selezionata a livello industriale.
Ai camminatori vengono chieste preferenze e intolleranze, ma viene solitamente proposta una zuppa asciutta di grani e lenticchie, o farro con le verdure dell’orto di quel periodo, pomodori secchi, pecorino di Castel del Monte con il pane e noci di Solina o della cicolana.

I prodotti del Cammino del Gran Sasso: il Canestrato di Castel del Monte, DOP, e i salumi
Tra i prodotti di cui non perdere l’assaggio, ci sono sicuramente i formaggi, in particolare i pecorini ricavati dal latte degli animali locali. Il prodotto d’eccellenza è il Canestrato, DOP, «fatto col latte delle pecore che si incontrano il primo giorno, passando per Campo Imperatore, dove pascolano dalla primavera all’autunno con i pastori abruzzesi e i cani da guardia». Mangiano l’erba della piana – sono 300 le erbe commestibili per gli animali nella zona – e il loro latte prende il sapore a seconda della stagionalità e della fioritura, così ogni pecorino è diverso. Per essere DOP, il formaggio riceve una stagionatura di sei mesi e di recente alcuni produttori hanno cominciato a produrre il “grana di pecorino”, stagionando oltre 3 anni forme di grossa dimensione, tra i 10 e i 15 kg.
Se non siete vegetariani, non potete non assaggiare la Cicolana, un salame a forma di ferro di cavallo che viene prodotto con carne di suino di Castel del Monte, il maialino d’Abruzzo, piccolo, nero, molto resistente al freddo, le cui carni sono particolarmente saporite. «Tra i prodotti più apprezzati, – racconta Federico –, c’è poi la Cicolana di fegato». Negli ultimi paesi, si trova anche il tipico Salame schiacciato aquilano, che ha una sezione allungata in quanto, in fase di stagionatura, per aiutare il processo e mantenere la carne compatta viene posto sopra un peso.
Per accompagnare questi prodotti c’è il Cerasuolo d’Abruzzo, con le sue note di visciola, la ciliegia selvatica, ottimo anche per un abbinamento con carni bianche o pesce. «All’arrivo di ogni tappa, accanto al timbro, non può mai mancare un bicchiere di vino!», dice Federico.

Dove mangiare sul Cammino del Gran Sasso: ristoranti, botteghe e chicche
Sulla pagina del Cammino c’è una sezione dedicata ai ristoranti, dove vengono riportati quelli che dal primissimo anno hanno creduto nel cammino, ma ci siamo fatti dare qualche consiglio per tutti i gusti e per tutte le tasche, visto che nel frattempo hanno aperto nuovi locali che meritano uno stop.
A Castel del Monte potrete mangiare presso l’“Albergo Parco Gran Sasso”, il cui ristorante viene gestito dalla signora Loredana, che propone moltissimi primi piatti a base di pasta fresca. In centro ha riaperto quest’anno “Mariannina”, un emporio gestito da due sorelle che mettono in vendita i prodotti del fratello pastore, tra cui dei pecorini eccezionali. «Si tratta del vecchio market gestito dalla loro madre trent’anni prima: dopo un periodo fuori dal paese, hanno deciso di rilevare di nuovo i locali nel borgo vecchio, anche grazie al Cammino».
A Rocca Calascio “La Taberna” propone arrosticini e pallotte cacio e ova da ricordare, mentre a Calascio il “Bar del Falco”, gestito sempre da due sorelle, di cui una sommelier, propone degustazioni di vini e assaggi con chicche locali che, assicurano, non troverete altrove. Sempre a Calascio, per pranzo potete fermarvi da “Pane&Vino”, bottega nel cuore del centro storico della città alta che propone focacce gustose.
A Santo Stefano di Sessanio c’è un ristorantino, l’“Elisir del poeta”, che propone cucina vegana che non deluderà i carnivori. Consigliate anche la “Locanda sul Lago” e “Il Palazzo”, oltre a “Cuore Nero”, specializzato in tartufi.
A Barisciano potrete scegliere tra il ristorante “Monte Selva”, un classico, o l’home restaurant “La Tricagliese”, che offre però solo 8 posti, e va quindi prenotato. Pare che lì il vino scorra a fiumi! Prima di completare l’ultima tappa, a un’ora dalla fine, c’è il “Rifugio Montecristo”, ora di nuova gestione che propone una chicca che non troverete altrove: pecorino fuso con miele e scaglie di mandorle e un carpaccio di pecora delicatissimo.

Dove dormire sul Cammino del Gran Sasso
Non ci sono donativi sul Cammino del Gran Sasso, ma piccoli e curati alberghi e b&b che fanno parte di un tessuto urbanistico ristrutturato che mantiene l’anima medievale grazie alle pochissime costruzioni di stampo più moderno. Per mantenerla, sono stati coinvolti antropologi che hanno aiutato ingegneri e architetti nella ristrutturazione, per esempio della parte più antica di Castel del Monte, Calascio e Santo Stefano, così da recuperare armadi, letti e arredamenti coerenti con quelli dell’epoca. «Non abbiamo convenzioni per i camminatori, ma in generale i prezzi sono piuttosto bassi. A Santo Stefano fa eccezione il primo albergo diffuso d’Italia, il “Sextantio Albergo Diffuso”, in cui una notte può costare 300 euro: qualcuno durante il cammino sceglie di regalarsela».

Il Cammino del Gran Sasso e la nuova vita del territorio
Quello del Gran Sasso, Parco Nazionale istituito nel 1991, rimane a oggi una delle aree con la maggior biodiversità vegetale d’Europa, con circa 2300 specie. «Qui la natura è ancora selvaggia, perché siamo in pochi e non c’è stata una antropizzazione di massa come è avvenuto in molti luoghi alpini». E la tradizione si unisce a nuove possibilità: se prima i pastori avevano un costo di smaltimento della lana, ora è diventato un guadagno grazie al Progetto Pecunia, sponsorizzato dal Parco e portato avanti da donne che hanno riscoperto un’arte portata avanti dal Medioevo alla fine dell’Ottocento, tra lavaggio, cardatura, filatura e infine tintura della lana, con le erbe officinali del parco. «Oggi per legge non si può più lavare la lana come una volta, quindi i primi passaggi vengono affidati a un’azienda esterna, ma poi si torna a tingerla con i frutti del territorio, ottenendo un colore sfumato e sempre unico, che dà una lana al tocco molto diverso e più vivo rispetto a quella industriale».
Nel 2025 il Cammino del Gran Sasso avrà ospitato quasi 5mila escursionisti – l’anno scorso erano 3mila – ed è oggi il quinto cammino più ricercato sul portale Cammini d’Italia. La partecipazione e gli effetti del Cammino hanno in pochi anni nutrito il tessuto locale, come spiega Federico. «Prendi Barisciano, il paese da cui provengo io, che non ha mai avuto una vocazione turistica, perché si trova ai confini del parco e ha subito quindi una maggiore urbanizzazione. Nel 2019 c’erano, insieme alla mia, solo quattro strutture, oggi ce ne sono 24». Più il cammino cresce, e il territorio viene vissuto e scoperto, più quest’ultimo può continuare a sua volta a crescere, dando nuove possibilità a chi vive tutto l’anno in queste aree.
Se vi è venuta voglia di percorrere il Cammino, trovate tutto quello che vi occorre sapere nel nostro focus e sul sito del Cammino del Gran Sasso.