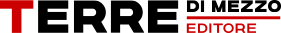Compriamo di continuo per un mix di impulsi psicologici, condizionamenti sociali ed economici; ma cambiare abitudini, incentivare la riparazione e premiare i prodotti durevoli potrebbe avere effetti enormemente positivi su di noi, sulla società e sul Pianeta.
I meccanismi psicologici e la gratificazione a breve termine
Perché non riusciamo a smettere di comprare cose nuove? È una domanda che mi pongo – o cerco di pormi! – sempre più spesso, quando mi trovo a desiderare qualcosa di cui non ho bisogno. Ne possiedo già una versione, solo un po’ rovinata o fuori moda, e posso quindi farne a meno? È qualcosa che davvero potrebbe servirmi, o, bombardata dalle inserzioni su social, sono semplicemente tentata da un oggetto o un indumento che, siamo sinceri, non userò più di un paio di volte? Sono sempre più allenata a rendermi conto dei meccanismi di cui mi trovo vittima e a dire di no, ma non riesco ancora a esserne del tutto immune.
Esiste una parola per definire la dipendenza dallo shopping, “oniomania”, dal greco “mania di comprare ciò che è in vendita”, utilizzata a partire dal 1915 grazie allo psichiatra Emil Kraepelin. Senza arrivare a questo disturbo compulsivo, condizione estrema che viene trattata come dipendenza, sono sicura che è capitato a tutti, almeno una volta, di cadere in un meccanismo di acquisto impulsivo. Questo viene reso più facile nel mondo digitale dall’utilizzo di carte di credito e metodi di pagamento che non ci permettono di vedere il denaro come qualcosa di “reale” o ci consentono di rateizzare, e incentivato da tecniche che sfruttano la gratificazione a breve termine con cui cerchiamo di rispondere a noia, stress, ansia.
Come spiegano molti studi, tra cui “Cost Conscious? The Neural and Behavioral Impact of Price Primacy on Decision-Making” (Journal of Marketing Research, 2014), il nostro cervello è in qualche modo programmato – ed è sempre più predisposto, grazie ai meccanismi sfruttati dai social media – per ricevere gratificazioni a breve termine. Quando prendiamo la decisione di acquistare qualcosa non solo vengono attivati segnali neurologici, ma si verifica anche una complessa interazione tra emozioni, desideri, necessità e pressioni esterne. I comportamenti di acquisto compulsivo forniscono un temporaneo sollievo a sensazioni di disagio, in cui la sensazione di gratificazione, sempre più lieve e più breve, è seguita da crescente frustrazione e senso di colpa. Ed ecco che si finisce vittime di un circolo vizioso.
Un meccanismo che ha radici antiche
La verità, è che ancora prima di entrare nell’era consumistica odierna e di questo tipo di dipendenze, il nostro cervello si è ritrovato, per motivi di sopravvivenza, a dover porre attenzione nei confronti di tutto ciò che è nuovo: da un frutto commestibile da raccogliere per rispondere alle esigenze di nutrimento, alla presenza di predatori che potevano costituire una minaccia. Una questione di vita e di morte ricompensata da una scarica di dopamina – neurotrasmettitore del benessere che scatena in noi reazioni positive di fronte alla novità –, fondamentale nel meccanismo evolutivo per memorizzare le esperienze.
Dalla sopravvivenza, però, con la diminuzione dei pericoli e soprattutto la moltiplicazione delle opportunità, siamo passati al consumo, arrivando all’eccesso. La Neurochirurga Ann-Christine Duhaime, nel saggio “Minding the Climate” spiega in che modo siamo diventati vulnerabili alle gratificazioni a breve termine: evolutosi in tempi di scarsità, il cervello preferisce, rispetto a risultati più incerti e lontani, i benefici istantanei. È facile, in questi automatismi, dimenticarci dell’impatto che possiamo avere sul lungo termine su noi stessi e sul Pianeta che ci circonda.

Identità, status e marketing
L’acquisto di nuovi beni e oggetti è spesso legato a bisogni emotivi profondi: il possesso risponde a esigenze come la ricerca di status, di identità e di felicità. Spesso, infatti, non compriamo oggetti solo per una loro eventuale utilità, ma perché tramite essi vogliamo comunicare qualcosa agli altri. Attraverso le nostre scelte ci definiamo: conformandoci a – o distanziandoci da – quello che è un determinato modo di consumare, indossando dei capi e degli accessori, utilizzando un certo smartphone, e così via, diciamo al resto del mondo qualcosa di noi.
Il marketing fa leva proprio su questo, cercando di convincerci che per mostrare il nostro valore serva possedere un determinato modello – l’ultimo, e parliamo in questo caso di obsolescenza percepita, quando cioè un oggetto che possediamo ci sembra meno desiderabile in quanto ormai superato da qualcosa di più attraente. A questa, si aggiunge l’obsolescenza programmata, per cui i prodotti appaiono progettati per durare sempre meno e diventare in poco tempo “superati” anche rispetto al loro effettivo funzionamento.
Il fenomeno del fast fashion è l’esempio più citato ed evidente di incentivo all’acquisto rapido e continuo, con prodotti che diventano sempre più “usa e getta”. Per fortuna, possiamo allenarci a prestare sempre maggiore attenzione a tutti questi fattori per guardarli in modo critico e consapevole e adottare comportamenti più sostenibili.

Riparare gli oggetti per riparare il Pianeta
Secondo i dati di McKinsey, rispetto a 15 anni fa indossiamo i vestiti che possediamo per il 36% del tempo in meno. Solo il settore dell’abbigliamento, viene stimato responsabile di circa il 10% delle emissioni globali di carbonio, a causa di una filiera molto lunga, che comincia dall’approvvigionamento delle materie prime (tra operazioni di estrazione e deforestazione), passa per il consumo di risorse energetiche e idriche per la produzione, e arriva alla distribuzione, per poi passare al suo smaltimento.
Anche comprare oggetti usati, per quanto sia decisamente preferibile e possa permetterci di ridurre parte del nostro impatto, risponde a una logica di consumo e implica dei costi. Basti pensare alle emissioni delle spedizioni attraverso cui spesso ci facciamo recapitare i capi e gli oggetti “pre-loved” che ordiniamo. Per cominciare a fare davvero la differenza dovremmo sforzarci, il più possibile, di acquistare quei prodotti che davvero ci servono, scegliendo i rivenditori attenti alla filiera e ai costi ambientali e, soprattutto, riparando. Anche perché molti degli abiti e degli oggetti che smettiamo di utilizzare, se non decidiamo di riutilizzarli, riciclarli o donarli a qualcuno che possa allungarne la vita, finisce in discarica, e spesso in Paesi lontani che si trasformano in deposito per i nostri rifiuti.
Ma perché, se riparare potrebbe permetterci di ridurre i nostri consumi e le emissioni, non lo facciamo? Perché spesso, nell’economia di scala, comprare oggetti nuovi prodotti in serie ha un costo minore (spesso fabbricati in Paesi con manodopera a basso costo) che procedere alla riparazione per mano di qualche professionista (che nei nostri Paesi ha costi più alti). Vi è mai capitato di portare una maglia a cui tenete a rammendare? Le figure specializzate sono spesso difficili da trovare e, giustamente, hanno un costo per il loro lavoro. Per non parlare, in caso di oggetti elettrici ed elettronici, di tutti quei produttori che limitano l’accesso ai pezzi di ricambio e l’autonomia dei riparatori indipendenti.

Il diritto alla riparazione e una nuova forma di identità
Il movimento internazionale del Right to Repair, nato negli Stati Uniti a metà del Novecento, è oggi sempre più diffuso in tutto il mondo e proclama il diritto a poter riparare ciò che possediamo e incoraggia a progettare prodotti più durevoli, modulari e smontabili. Un diritto sia dei consumatori che dei tecnici di avere accesso a pezzi di ricambio, manuali, e strumenti necessari.
Dal 2021 in Europa i produttori di grandi elettrodomestici hanno ricevuto man mano l’obbligo di fornire ricambi per almeno 7-10 anni e grazie alla Commissione europea queste regole sono state estese a smartphone e tablet: dal 20 giugno 2025 è stato imposto anche ai produttori di rendere disponibili pezzi di ricambio sul mercato europeo per almeno 7 anni dopo che il modello è stato tolto dal mercato. Negli Stati Uniti, invece, nel 2022 lo Stato di New York ha approvato la prima legge che obbliga le aziende a condividere manuali e componenti per l’elettronica.
Ci sono aziende di abbigliamento outdoor, come ad esempio Ferrino, Salewa, Patagonia e molte altre, che hanno programmi specifici di riparazione dei propri capi. Sul sito di Ferrino ci sono tutte le istruzioni per inviare i capi e gli oggetti in riparazione; Salewa promuove un’esperienza circolare e sta attivando presso lo store di Bolzano un programma di riparazione e uno per dare una “Second Life” ai prodotti. Il programma Patagonia Worn Wear permette sia di richiedere riparazioni in negozio, sia offre tutorial per procedere alla riparazione fai-da-te; anche Black Diamond propone un analogo programma di riparazione, “Reroute” dal 2023, e Calze GM propone un servizio di riparazione qualora non si fosse in grado di rammendare da sé le proprie calze.
Il diritto alla riparazione va al di là di un mero aspetto tecnico: si tratta di un cambiamento di paradigma culturale, in cui i valori fondamentali sono la cura e la longevità in contrapposizione alla varietà e alla rapidità. E se riparare, come nell’antica tecnica del kintsugi, potesse diventare motivo di identità – avere un oggetto unico nel suo difetto, e per questo ancora più bello e prezioso, – e di statement – la cura nei confronti del mondo e di conseguenza degli altri? Meno rifiuti, un uso minore di risorse, emissioni ridotte, nuovi posti di lavoro legati alla manutenzione.
Non dobbiamo smettere di acquistare in toto, bensì allenarci a riconoscere quando stiamo rispondendo a un bisogno reale e quando invece siamo in cerca di una gratificazione momentanea, compiendo scelte consapevoli e dimostrando di poterci prendere cura di noi e del Pianeta.