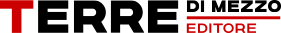Ci sono incontri che profumano di strada, di passi condivisi e di silenzi che parlano più di mille parole. Quello con Dario di NoisyVision è uno di questi. Camminatore, sognatore, e voce di chi crede che la vista più profonda non passi dagli occhi ma dall’ascolto reciproco. Con lui si riscopre che ogni cammino è, prima di tutto, un viaggio interiore: un modo per ricalibrare il passo, per imparare a vedere con il cuore e per riconoscere che la vera accessibilità nasce dallo sguardo con cui ci guardiamo, non solo dai sentieri che percorriamo. Lo abbiamo intervistato per scoprire di più sul suo mondo in cammino che nasce da Noisy Vision, il nome che ha dato vita al blog che è poi diventato un progetto di vita. Noisy Vision (link) oggi è una ONLUS che si propone di diffondere la conoscenza delle disabilità sensoriali e si occupa di creare occasioni formative, ricreative e di incontro che siano inclusive e accessibili.
Quali sono le difficoltà più grandi che hai incontrato nella realizzazione del progetto NoisyVision?
La sfida più grande rappresenta il cuore della nostra mission: cambiare la percezione della disabilità e, soprattutto, delle persone che la vivono. Questo vale per entrambe le parti. Spesso, sono le stesse persone con disabilità a limitarsi in questa percezione, mentre i normodotati tendono ad affrontare l’argomento con un approccio assistenzialista.

Nello specifico, è molto difficile far capire a chi ama camminare che farlo insieme a una persona non vedente non è un gesto di assistenza, ma una vera e propria condivisione alla pari. Un’altra grande difficoltà è la perseveranza: la capacità di continuare anche quando si avvertono fatica e demotivazione, ricordando sempre l’obiettivo, specialmente nei momenti di sconforto.
Nel tuo libro racconti di quando hai creato NoisyVision, che è iniziato come il blog in cui scrivevi mentre vivevi a Berlino. In che momento hai deciso di tornare in Italia? L’hai fatto avendo già chiaro il tuo progetto o è qualcosa che hai costruito nel tempo?
È stato un processo molto graduale, che ha riguardato sia il mio rientro in Italia, sia la costituzione dell’associazione, nata ufficialmente sei anni dopo l’apertura dell’omonimo blog. Sapevo che prima o poi sarebbe accaduto, perché volevo costruire un progetto italiano, pur mantenendo un respiro internazionale. Tagliare il cordone ombelicale con Berlino è stato difficile, perché amo profondamente quella città. Alla fine, però, è stata la vita a decidere per me, o meglio, la vita di mia figlia.
Hai mai ripercorso il cammino di Santiago? E se no, hai mai pensato di tornarci? Come pensi sarebbe ripercorrerlo oggi dopo tanti anni?
Purtroppo non sono mai tornato sul “Camino”. E in effetti vorrei tanto farlo. Continuo a ripetere che è un viaggio che tutti dovrebbero fare, possibilmente da soli. È un percorso che consiglierei anche alle persone cieche perché sicuramente troverebbero ogni giorno qualcuno disposto ad accompagnarli.
Vorrei tanto tornare, anche per vedere se e come è cambiato in vent’anni. Vorrei tornare per ritrovare un po’ di quel ragazzo che dormiva all’addiaccio in cerca di un posto nel mondo. Credo che tornerò con la mia famiglia. Sarà bello farlo in tre. Io e Marina, la mia compagna, ci siamo conosciuti in cammino. Nostra figlia Luna è figlia del cammino. Fare un cammino insieme sarà meravigliosamente necessario.
Quale credi che sia il cambiamento più grande di cui hanno bisogno oggi i cammini per diventare più accessibili?
L’accessibilità dei cammini è un tema molto complesso. Credo che il cambiamento più grande da attuare sia lo spostamento del significato: da cammini per persone con disabilità a cammini per tutti. Quando tutti avranno capito che l’accessibilità non è un tema esclusivo per le persone con disabilità, sarà più semplice lavorare al miglioramento, perché si guarderà all’accessibilità come un’opportunità anziché un limite. Inoltre, penso che sia necessario lavorare sull’intensificazione del senso di comunità, di rete e di partecipazione.
Quali sono le barriere meno visibili ma più impattanti che hai incontrato lungo i cammini?
- La barriera dell’incertezza (Il carico mentale della pianificazione):
Questa è forse la più pesante. Una persona senza disabilità può partire con uno zaino e un certo grado di improvvisazione. Una persona con esigenze specifiche non può permetterselo.
Nel mio caso devo accertarmi di poter arrivare a fine tappa prima del buio, che siano disponibili le tracce GPS, …
Questo carico mentale è estenuante e trasforma un’esperienza di libertà in un complesso progetto di logistica, magari vissuta con ansia che mina lo spirito del cammino. - La barriera sociale dell’aspettativa (Essere “Eroe” o “Paziente”):
Lungo il cammino, una persona con disabilità viene spesso percepita in due modi opposti, ma ugualmente limitanti: o come un eroe da ammirare (“Che forza che hai, sei un’ispirazione!”) o come un paziente da assistere (“Hai bisogno? Faccio io, stai fermo”). Raramente viene vista semplicemente come un pellegrino, alla pari con gli altri. Questo crea una distanza. Da un lato, l’etichetta di “ispirazione” mette una pressione non richiesta; dall’altro, l’approccio assistenzialista (spesso definito “paternalismo benevolo”) toglie autonomia e dignità - La barriera dell’isolamento involontario:
La socialità del cammino si crea la sera, negli ostelli, cenando insieme. Molte strutture a basso costo, tipiche dei pellegrini, non sono accessibili. Questo costringe chi ha una disabilità a cercare soluzioni alternative (alberghi più costosi, strutture fuori dal percorso), perdendo così i momenti di condivisione che sono il cuore dell’esperienza.
Banalmente anche la scarsa illuminazione di alcuni luoghi non favorisce le persone ipovedenti.
Si cammina di giorno, magari insieme, ma la sera si rimane soli. È una barriera invisibile che colpisce direttamente l’anima del viaggio. - La Barriera Economica Nascosta: l’accessibilità ha un costo nascosto. Le strutture accessibili sono spesso più care. Se un tratto non è percorribile, bisogna pagare un trasporto. L’equipaggiamento specializzato (come handbike o joelette) è costoso. Questo rende il cammino, un’esperienza tradizionalmente “povera” e democratica, un lusso per pochi, introducendo una discriminazione basata sul censo.
Cosa succede nella relazione con gli altri quando si cammina insieme per giorni e si superano insieme difficoltà concrete?
La fatica fisica e il focus sull’obiettivo comune spogliano le persone dalle loro armature sociali. Non c’è più tempo o energia per le convenzioni, le maschere o i ruoli rigidi. Si arriva a un livello di autenticità e vulnerabilità molto più veloce che nella vita quotidiana. Le conversazioni diventano immediatamente più profonde, perché le preoccupazioni concrete (acqua, riparo, passo) superano le conversazioni superficiali.

Qual è la difficoltà maggiore che trovi nel guidare un gruppo con esigenze diverse?
La gestione del ritmo e del tempo è una difficoltà che riguarda tutte le guide e tutti i gruppi. Se ci sono persone con disabilità che camminano particolarmente lente, il rischio è quello di attribuire la lentezza alla disabilità stessa. Inoltre, comunicare in modo efficace con un gruppo eterogeneo richiede uno sforzo enorme. Bisogna assicurarsi che le istruzioni siano chiare per chi è meno esperto, e accessibili per chi ha esigenze sensoriali diverse.
Con le sue parole Dario ci ha mostrato un pezzettino di ciò che ha costruito e che approfondisce nel suo libro “Guarda dove cammini”.(link) Una storia di crescita e consapevolezza, che mette a disposizione di chiunque cerchi profondità e riflessione. Le barriere che racconta – visibili o invisibili – sono le stesse che ognuno di noi incontra, anche senza una disabilità: la paura di dipendere, la difficoltà di affidarsi, la fatica di mostrarsi fragili.
Eppure, passo dopo passo, il cammino insegna che insieme si può andare più lontano. Quando il ritmo si adatta, quando la condivisione diventa naturale, la disabilità sparisce e resta solo ciò che conta davvero: la bellezza del viaggio e la potenza dell’incontro.