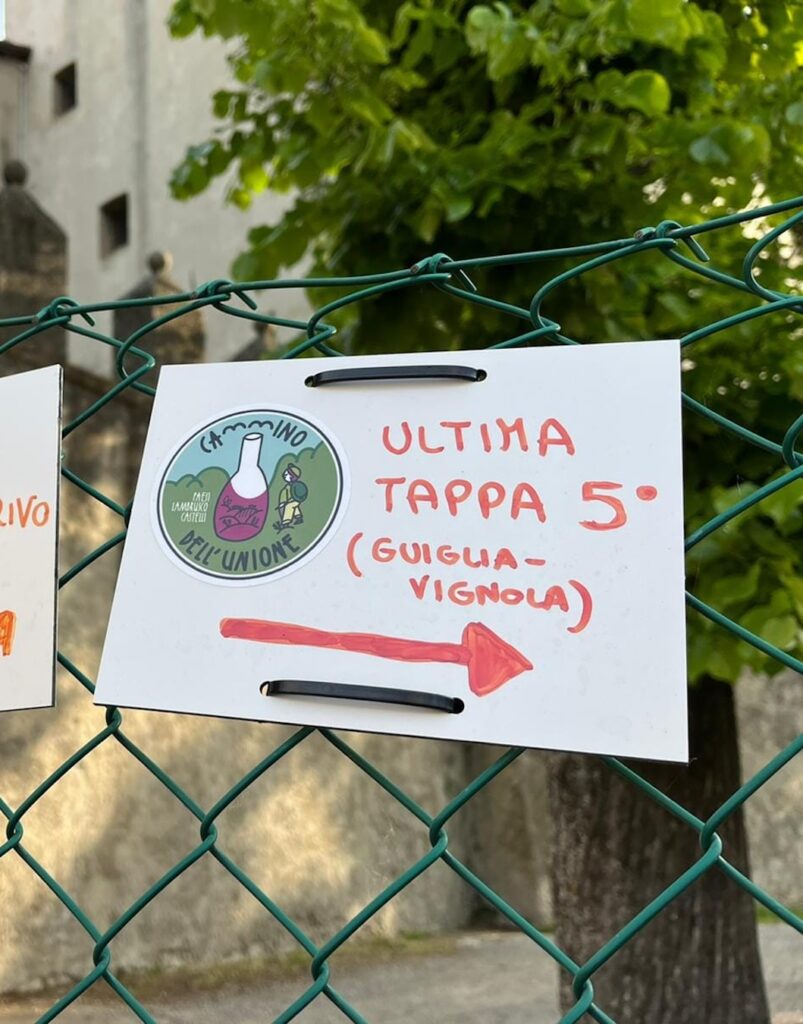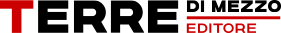Un itinerario di 109 km tra colline, castelli e sapori autentici dell’Emilia Romagna. Il Cammino dell’Unione unisce paesaggi collinari e tappe gastronomiche: dalla ciliegia moretta di Vignola all’aceto balsamico tradizionale, dalle crescentine ai ciaci, fino a vini frizzanti e liquori della tradizione. In questo articolo scopriamo il territorio attraverso i suoi sapori e le storie che li raccontano.
Camminare significa immergersi nella natura, incontrare persone e storie, riscoprire sé stessi. Ma anche gustare i sapori dei luoghi attraversati, che raccontano tradizioni e identità. Da questo intreccio nasce il nostro viaggio tra i Cammini d’Italia e le loro eccellenze enogastronomiche. Dopo il primo articolo dedicato alle meraviglie enogastronomiche del Cammino del Gran Sasso, torniamo a parlare di cibo e specialità del territorio con il Cammino dell’Unione.
Il Cammino dell’Unione: storia e tappe
Il nome di questo recente Cammino, tracciato per la prima volta nel 2021 da Federica Bergonzini e Giuseppe Leo Leonelli, oggi gestito da una quindicina di volontari e promosso da Unione Terre di Castelli è stato scelto per il territorio che attraversa, quello appunto delle Terre di Castelli: ognuno degli otto comuni che ne fanno parte ha infatti il proprio castello, tra borghi medievali e la natura rigogliosa delle colline modenesi. Il nome vuole anche richiamare un tentativo di allontanarsi dall’individualismo, perché è insieme che ci si aiuta e che si raggiungono mete impensabili.
Le tappe di questo percorso ad anello di 109km sono 5, e cominciano dal fiume Panaro e da Vignola per raggiungere le colline di Castelvetro, dove nasce il Lambrusco Grasparossa, passare i Sassi di Roccamalatina, attraversare i boschi di castagno prima di Zocca, assaggiare l’Aceto Balsamico tradizionale di Modena a Spilamberto e ritrovarsi nella patria della ciliegia. Un itinerario che non può prescindere dalle specialità della cucina emiliana.
Ogni paesino è legato ad almeno un prodotto tipico, ma, come ci racconta Giulia Tamarri, travel designer del team turismo e marketing di Unione Terre di Castelli, che collabora nella promozione agroalimentare ed esperienziale del territorio, «ce ne sono tanti altri, potremmo parlarne per un mese!». I cibi più raccontati sono sicuramente quelli più ricchi e di origine animale, ma non mancano specialità vegane, come l’aceto, le ciliegie e tanti altri frutti e ortaggi.

Vignola e la sua ciliegia
Il cammino parte da Vignola, legata com’è noto alla ciliegia, che ha anche il riconoscimento IGP: presidio Slowfood, la ciliegia moretta è il frutto più autoctono in assoluto, e insieme il più dimenticato. Si tratta di una ciliegia dolcissima, con la pelle sottile e molto scura: cresce su alberi alti e per questo è difficile da raccogliere. Inoltre, poiché è delicata, è difficile il suo trasporto senza che si ammacchi, e ha un periodo di maturazione molto breve.
Per questo, nonostante il suo sapore straordinario, è stata pian piano abbandonata, soprattutto da quando è cominciata l’importazione di duroni e ciliegie americane. I duroni di Vignola oggi raggiungono calibri molto grandi, hanno una polpa dolce e succosa. Ci sono aziende che producono diverse varietà, ciascuna delle quali ha una durata e un proprio ciclo: i periodi sono leggermente cambiati a causa del riscaldamento globale, ma in generale la moretta si trova da fine maggio alla prima di giugno, mentre le altre ciliegie continuano a essere raccolte fino a tutto il mese di luglio.
Spilamberto e il suo aceto
Lasciata Vignola, entriamo nel territorio di Spilamberto e parliamo ora dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, che si distingue da quello “normale” perché è DOP – con un disciplinare esclusivamente riservato al territorio di Modena. L’unico ingrediente di questo aceto è il mosto cotto, che viene invecchiato in botti di diversi legni, ognuno dei quali conferisce un proprio aroma: non può mancare il ciliegio, poi ci sono il gelso, il castagno, l’acacia… La particolarità è come viene prodotto: viene consegnato e invecchiato in quelle botti per minimo 12 anni, e le sue caratteristiche sono molto diverse da qualsiasi altro aceto. Gli abbinamenti possibili sono tantissimi: per esaltare un qualsiasi piatto, da quelli più semplici e scontati ai più insoliti, ne bastano poche gocce. Non per niente viene chiamato l’oro nero di Modena!
La classica frittata alla cipolla, nella sua semplicità è già di per sé gustosa in modo disarmante: ecco che con qualche goccia di aceto raggiunge un altro livello. Per non parlare dei tortelloni di ricotta – meglio se la ricotta è quella del caseificio di Rosola a Zocca. Se avete l’occasione, potrete sperimentarli anche con una riduzione di ciliegia moretta, oppure di lambrusco. Un altro abbinamento salato vincente è quello con il risotto al Parmigiano Reggiano. E per concludere in dolcezza, basterà versarne qualche goccia su una coppa di fragole e gelato.
Se assaggiarlo non è abbastanza, potete visitare il Museo del Balsamico Tradizionale di Spilamberto, allestito presso Villa Comunale Fabriani e che offre comunque qualche assaggio, oppure visitare le acetaie private in cui potrete fare anche delle degustazioni più complesse – come l’Acetaia dei Bago, al confine tra le campagne di Vignola e di Spilamberto, e l’Acetaia Vecchia Dispensa nel borgo di Castelvetro di Modena, proprio sul Cammino.

Castelnuovo, tra prosciutto e crescentine
Il prosciutto crudo non esiste solo a Parma: in queste zone potrete scoprire il Prosciutto di Modena DOP. Ma non solo: ciccioli, coppa, salami di ogni tipo, che i locali abbinano al tipico pane locale, le cosiddette “tigelle”, anche se vengono chiamate così erroneamente. La tigella infatti anticamente era un disco di terracotta su cui venivano cotte le crescentine, dopo essere uscito rovente dal camino. È dunque “crescentina” il nome corretto, dal verbo crescere, perché l’impasto “cresce” durante la cottura, che però spesso lascia il posto a quello più utilizzato.
Castelnuovo non è esattamente sul Cammino, ma proprio accanto. Tutti, o quasi, durante il Cammino dell’Unione vanno a provare crescentine e gnocco fritto dalla Santina. Lo gnocco fritto i locals lo mangiano a qualsiasi orario: come aperitivo, con una fetta di prosciutto e un calice di Pignoletto, ma anche a colazione, pucciandolo dentro il cappuccino.
Castelvetro e il Lambrusco Grasparossa
Questo territorio durante il foliage autunnale è ancora più bello: percorrere il Cammino tra ottobre e novembre è quindi una scelta perfetta. Ancora più perfetta, se a fine tappa decidiamo di concederci un bel bicchiere di Grasparossa. Al contrario di altre varietà di Lambrusco, come il nome stesso suggerisce, è un vino molto molto colorito – ed è anche quello che troviamo sul logo del Cammino, perché si sposa con tutto il cibo che vi troviamo.
In coda alla prima tappa il cammino passa da Levizzano Rangone, che custodisce il Museo del vino e della società rurale Rosso Graspa, ospitato nel castello del paese e visitabile nel weekend. Lungo il percorso ci sono anche tante altre cantine che aprono le porte ai camminatori, come quella del vignaiolo Vittorio Graziano, tra i pionieri del vino naturale in Italia, La Piana, Fattoria Moretto, Chiarli.
Sia Lambrusco Grasparossa che Pignoletto, vino bianco tipico di Savignano sul Panaro, sono entrambi frizzanti, perfetti per pulire il palato in abbinamento ai cibi un po’ grassi locali. Se volete approfondire anche il Pignoletto potete farlo nelle terre di Savignano, che con il suo colle fa parte del disciplinare insieme a Bologna: il vitigno a bacca bianca si distingue per la forma a pigna del grappolo, da cui si ricava un vino frizzante o spumante di color paglierino. Per una visita, tra i vari, ci sono il Podere Fiorini e la Cantina Bergonzini.

Marano sul Panaro, un tripudio di frittura
Passando da Marano sul Panaro, nella seconda giornata di cammino, famoso per il suo luppolo, non potete perdere il Calzagatto, soprattutto da ottobre e in avanti, per i mesi invernali: si tratta di una polenta con dentro i fagioli, che poi viene fritta – e ovviamente non può mancare una sagra a esso dedicata in novembre. Ma perché si chiama “calzagatt”?
Leggenda vuole che una “resdora” – parola dialettale che indica la reggitrice, ovvero la donna di casa che si occupava tra le varie cose anche del cibo e che era quasi sempre un’ottima cuoca – stesse preparando per un pranzo la polenta in una pentola, e i fagioli in un altro tegame. Pronti questi ultimi, li aveva messi in tavola, per poi tornare a recuperare la polenta: camminando verso la tavola, inciampò nel gatto, rovesciandola sui fagioli. Di certo non avrebbe buttato via quel cibo: ecco che decide di friggerli insieme, dando vita alla nuova ricetta.
Guiglia e il suo insolito Borlengo
Nasce in queste zone e si mangia con le mani! Il Borlengo è una sfogliata tipica di Guiglia che viene tradizionalmente condito e accompagnato con il lardo. Un piatto decisamente non vegano, visto che all’interno di questo filo sottilissimo di sfoglia, chiusa e cotta in padelle chiamati “soli”, insieme al rosmarino ci sono strutto e parmigiano reggiano.
Nato in questo paesino nel 1266, ai tempi del conte Ugolino e del suo esilio nel Castello di Montevallaro a opera dei Guelfi modenesi, la famiglia degli Algani, il Borlengo è sempre stato considerato un cibo povero, fatto con poca farina e tanta acqua. “Un Burlèng, un bicèr ed vèin e as campa ‘na vèta” (un borlengo, un bicchiere di vino e si campa una vita), si diceva all’epoca, quando i borlengai, specialisti dotati dell’attrezzatura necessaria, giravano di casa in casa per cucinarli.

Zocca e il suo marrone
Patria di Vasco Rossi, Zocca è anche terra di marroni. La tradizione montanara è in generale molto legata alla castagna, e qui non si fa eccezione: dal marrone si ricavano in particolare i Ciaci, un incrocio tra piadine, per la loro forma tonda e croccante, e le crepes, perché possono essere sia dolci che salati. Fatti con la farina di castagna, acqua e olio, il loro interno viene farcito con ricotta e miele sempre di castagno.
Per la cottura vengono utilizzate delle padelle speciali chiamate “cottole”: a differenza delle padelle tradizionali, che hanno un manico attaccato a un recipiente, queste sono costituite da un unico pezzo di metallo, completamente piatto, il cui manico è lungo come un avambraccio. Per cucinare i ciaci se ne usano due.
E per concludere, un bel digestivo: il nocino!
Secondo la tradizione, ogni 24 giugno le “streghe” andavano a raccogliere i malli di noce per fare il nocino, liquore tradizionale emiliano ottenuto dall’infusione dei malli verdi di noce — cioè il frutto ancora acerbo, raccolto prima che il guscio interno si indurisca — in alcol, zucchero e spezie. Ancora oggi, si prepara tradizionalmente nella notte di San Giovanni (il 24 giugno appunto), quando si dice che le noci abbiano le proprietà migliori.
L’infusione dura all’incirca 40 giorni: viene esposta al sole o comunque al caldo, poi il liquido viene filtrato e lasciato maturare per almeno 3-6 mesi (più invecchia, più diventa morbido e aromatico) e risulta in un nettare molto scuro, con una gradazione tra i 35 e i 40 gradi. Sul cammino lo potete trovare dappertutto, ma l’Ordine del Nocino, che porta ancora oggi avanti la tradizione di questo liquore tipico fatto in casa da tutte le famiglie, si riunisce all’interno del Torrione Medioevale di Spilamberto.

Per tutte le informazioni sul Cammino dell’Unione potete visitare il sito ufficiale, mentre su Terre di Castelli potrete approfondire luoghi, esperienze, sagre ed eventi. Ringraziamo Giulia Tamarri, per le preziose informazioni. Le immagini sono dell’archivio di Unione Terre di Castelli.